


































Da bambina i libri mi salvavano continuamente. Ero una bambina alta e troppo timida per essere così alta, molto brava a scuola, dunque secchiona in un’epoca in cui nessuno si era sognato di coniare la smagliante etichetta di nerd come un attestato di brillantezza.
Ero scarsa in educazione fisica, come ogni secchiona che si rispetti, e gli sport di squadra con la palla mi terrorizzavano. Oltretutto, i miei genitori avevano preso delle decisioni pedagogiche forse un po’ in anticipo sull’allegro consumismo degli anni ’90: niente TV, niente Nutella, niente Barbie. Per merenda, a scuola, tutti avevano la Fetta al latte, io una banana – da cui la mia attuale avversione per il frutto, ma questa è un’altra, lunga, storia.
Tutte le bambine e i bambini il pomeriggio guardavano Bim Bum Bam, io no. A scuola sentivo riferimenti che coglievo per spizzichi e bocconi, Sailor Moon ci ho messo anni per capire chi fosse, così come Lady Oscar.
Io che non guardavo la televisione, allora, leggevo, leggevo tantissimo. Mi sembrava l’unica cosa da fare; evidentemente nell’infanzia si ha bisogno di storie. Leggevo e i libri mi creavano intorno una protezione; perché ero sì una secchiona scarsa a pallavolo, ma ero anche quella che le storie le sapeva raccontare. Ero quella dei libri, e in un senso sottile, malgrado la pallavolo e le banane, questo mi dava una certa qual dignità, un piccolo ruolo, di cui forse da bambini abbiamo bisogno quanto abbiamo bisogno di storie.
A furia di leggere ero diventata brava a scrivere, anche questo a scuola si sapeva; mi sarei risparmiata volentieri le letture pubbliche dei miei temi, io in piedi accanto alla lavagna, santo cielo, perché non ero più bassa, bassissima, da nascondermi sotto un banco?, ma ecco, nonostante tutto sentivo nel mio rapporto con le parole qualcosa di un po’ magico che mi salvava, in parte, dalla condanna a essere diversa, a essere isolata, quella con la banana per merenda che non sa chi è Candy Candy.
Dell’incantesimo dei libri mi appropriavo a modo mio. Sentivo di aver bisogno di un mondo parallelo, di un rifugio dalla vita quotidiana, con i suoi cieli grigi, i compiti che già allora, benché secchiona, rimandavo alla sera ritrovandomi sempre indietro, la ginnastica e le banane, un mondo che era precisamente quello che mi si apriva con i libri, molto congeniali anche perché mi risparmiavano la fatica del viaggio e in un battibaleno mi catapultavano in una Londra vittoriana o nella Pennsylvania delle sorelle March o addirittura in Malesia; ma avevo bisogno, anche, di un modo per fermare la vertigine di certe felicità, di certi momenti che non mi pareva bastassero, se vissuti soltanto.
Il giorno che mi resi conto della fortuna che avevo a passare una parte dell’estate con mia sorella e le nostre nonne in una casa sull’Appennino, fra i boschi di abeti e le cerrete, mi ricordo ancora l’urgenza che mi prese, di scrivere di quelle giornate – sentivo che altrimenti le avrei perse.
Il giorno che nel cortile della mia scuola elementare, a Milano, di colpo tornava ad addensarsi l’ombra verde degli ippocastani, era primavera, si inaugurava la stagione dei gelati e delle sere lunghe, e anche quelle sere mi struggevano. Mi chiedevo se me le sarei ricordate, da grande; e oggi che sono grande, quelle sere di aprile a Milano io le cerco senza ritrovarle dentro le sere di tutte le città in cui ho abitato, ma il modello irreplicabile l’ho ben presente, perché allora me l’ero scritto. Il giorno che la mia prima gatta tornò dopo essere sparita per una settimana, il sollievo immenso di averla ritrovata; e ancora di più, l’emozione violenta di un altro giorno, sempre della stessa estate, quando dalla cuccia che le avevamo preparato sotto un comò arrivò un suono nuovo – era nato il suo figliolino, un micino che cerco, e ritrovo, ancora, ogni volta che vedo una vita piccola, appena cominciata.
Anche di quei sollievi e di quegli spaventi, avevo scritto, e non importa che i quaderni su cui li ho fermati siano andati persi; mi rimane il ricordo dello sforzo, della fatica di me bambina, ostinata come un mulo, nel voler trasportare in parole quello che sentivo. Certo goffamente, certo oggi se ritrovassi quei quaderni sorriderei, offendendo molto la stessa bambina; ma quella fatica, oggi lo so, era l’inizio di un apprendistato solitario.
Per molto tempo ho sognato di diventare una scrittrice, e non sapevo che bisogna stare attenti a quello che si desidera. Non conoscevo, allora, il potere formidabile delle preghiere esaudite; lo spaesamento del desiderio che diventa reale e ti costringe all’attrito con il mondo, con i mille piccoli impedimenti quotidiani, con le noie e gli inciampi. Soprattutto, con quella sensazione un po’ smarrita, tanto simile al momento in cui ci accorgiamo che quel tale che ci ha urtati sul métro ci ha sfilato il portafogli dalla borsa, di renderci conto che una cosa solo nostra non è più nostra, o almeno, non nostra e basta.
Insomma, ho sognato da bambina di fare la scrittrice, e non mi ero curata delle conseguenze. Ora inizio a conoscerle. Non che siano spiacevoli – tutto il contrario. È bello, e sarei un’ipocrita a negarlo, essere vezzeggiata, sentirsi dire: quella pagina lì mi ha parlato, o mi ha commosso, o mi ha fatto capire qualcosa che non riuscivo a mettere a fuoco. È bello che ci siano persone che ti chiedono quando uscirà il prossimo libro, perché lo aspettano, perché hanno voglia di leggere qualcosa che è uscito dalla tua testa, e un po’ come Atena quando esce dalla testa di Zeus, si manifesta con una forte emicrania paralizzante e poi è già pronto ad andarsene per il mondo, in una minuscola armatura che forse non lo proteggerà abbastanza. Però è bello. È bello sentirsi dire che le tue parole sono importanti, come potrei negarlo?
Ma proprio questi aspetti così gratificanti di un mestiere per altri versi arduo, sono forse i più pericolosi. Innanzitutto, innescano una sorta di dipendenza – una dipendenza affettiva? Forse sì, forse c’è anche quello: l’idea che se sarai abbastanza brava ti meriterai l’amore, altrimenti… altrimenti niente.
In secondo luogo, condizionano le tue scelte autoriali in maniere sottili, surrettizie, talvolta difficili da individuare. Come il pittore di un bellissimo racconto di Gogol, Il ritratto, che vittima di un incantesimo riesce, da spiantato giovanotto di talento, a diventare il pittore alla moda da cui tutta la buona società vuol farsi fare il ritratto perché nei suoi ritratti i difetti appaiono smussati, perché i suoi sono ritratti lusinghieri e la gente si compiace della lusinga. E accumula ricchezza e onori, e solo quando ormai è troppo tardi si rende conto che, pur di compiacere il pubblico, ha rinunciato a coltivare il talento che aveva. E le parole troppo tardi si trasformano in una rabbia cieca, come solo le rabbie che nascono da grandi dolori.
D’altronde, così come i modelli dei ritratti di quel pittore di Pietroburgo, i lettori hanno i loro diritti, e hanno ragione di esercitarli.
 Ilaria Gaspari: “Quello di disturbare, di turbare, di mettere in crisi i lettori, è un diritto sacrosanto, io credo, di chi scrive…”
Ilaria Gaspari: “Quello di disturbare, di turbare, di mettere in crisi i lettori, è un diritto sacrosanto, io credo, di chi scrive…”
A volte vogliono essere rassicurati. A volte vogliono sentirsi virtuosi. A volte vogliono “un messaggio”. A volte vogliono sentirsi intelligenti… A volte trovano libri che soddisfano questi desideri, altre volte trovano libri che li disturbano; e quello di disturbare, di turbare, di mettere in crisi i lettori, è un diritto sacrosanto, io credo, di chi scrive.
D’altra parte, è il minimo, visto che chi legge ha tutto il diritto di dire questo mi piace, questo non mi piace; di chiudere un libro senza sentirsi in colpa per aver sospeso la lettura; di essere provocato, stimolato, rinfocolato dalle parole, non semplicemente rassicurato.
Un problema ancora nebuloso ma reale, almeno a mio modo di vedere, per le autrici e gli autori oggi, è che – fermi restando questi diritti fondamentali, di chi scrive e di chi legge – i social convogliano, sia in chi legge che in chi scrive, l’idea di un’ingannevole prossimità che trasforma aspettative in pretese; una familiarità densa e persistente, che talvolta è anche piacevole, anzi, che può essere l’occasione perché nascano amicizie, confronti fecondi, nuove idee; ma rischia di trasformarsi in una stanza che è anche una prigione.
Senza rendermene conto lì per lì, mi sono sentita, a volte, come Paul Sheldon, lo scrittore che a un certo punto inizia a censurarsi da solo, pur di non contrariare – o pur di compiacere? – l’infermiera folle Annie Wilkes che lo tiene in ostaggio, in quella formidabile metafora del rapporto fra artista e pubblico che è Misery, il romanzo in cui Stephen King diede forma all’incubo del successo che lo strangolava dai tempi della pubblicazione del suo Carrie.
Paul Sheldon è noto per una serie di libri a vivaci tinte popolari, molto sentimentali, molto kitsch ai suoi stessi occhi. Il grande pubblico per questo lo adora, ovviamente la critica lo disprezza; e lui, che vuole riscattarsi da questo disprezzo, che desidera essere accreditato come scrittore serio, ha appena finito di scrivere un romanzo sofisticato, così diverso dalla saga di Misery. Proprio non si aspetta di finire prigioniero di un’infermiera fuori di testa, che lo costringerà a riprendere la storia della sua eroina preferita. Soprattutto, non si aspetta che l’infermiera, nonché sua “fan numero uno”, dopo aver letto il nuovo manoscritto gli possa manifestare un disprezzo che lo ferisce molto più del disdegno della critica. E che quindi la sua sfida, la sua pulsione più segreta e inconfessabile, diventi quella di accontentare il gusto di Annie, censurando le sue stesse velleità. E se i romanzi del ciclo di Misery, dopotutto, fossero davvero quelli che gli riescono meglio? Da vero volpone, King lascia la questione aperta; perché, da vero scrittore, sa evitare di scivolare dentro una morale univoca.
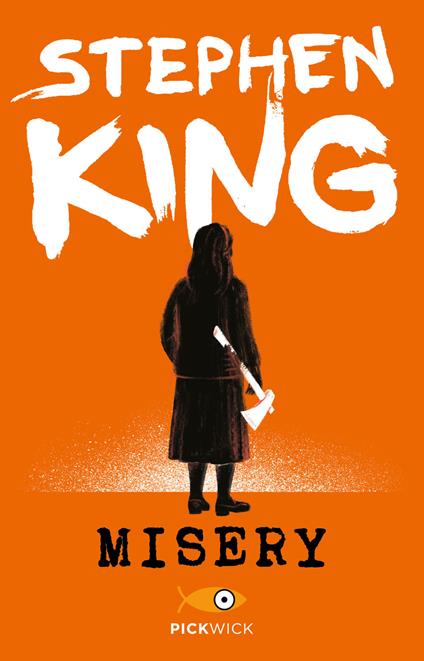
Il romanzo è del 1987, appartiene a un’età in cui l’avvento dei social era ancora ben al di là da venire, eppure, come molti grandi libri, riesce a illuminare, oltre al momento in cui è stato scritto, anche un futuro allora imprevedibile. Quello che negli anni ’80 in cui King scrive Misery riguardava solo chi vendeva centinaia di migliaia di copie, grazie ai social e all’esposizione universale che garantiscono si amplifica, diventa un fenomeno dalla portata molto più vasta. Qualcosa che non riguarda più l’autore di bestseller che vuol lasciar andare il personaggio che gli ha dato il successo e gli sembra averlo privato della libertà di invenzione così essenziale a chi scrive, ma anche chi ben più modestamente si arrabatta nel mondo delle lettere. Non solo chi vende 100,000 copie, ma anche chi spera di venderne 10,000, o 5,000, o pure 1,000. Non solo chi è strangolato dal successo, ma chi il successo lo sogna, e lo desidera, in una fantasticheria alimentata dalla competizione che i social argutamente attizzano, inibendo spesso la domanda fondamentale: ma poi, il successo, sarà davvero così desiderabile?
In questo acquario virtuale in cui tutti ci si tiene d’occhio, in cui sembra indispensabile (e dopo averlo fatto con relativa naturalezza anch’io, per molto tempo, come se fosse ovvio, ultimamente mi chiedo sempre più spesso: e se smettessi?, e piano piano ho iniziato a scordarmi di quell’articolo, o di quella recensione, e non è cascato il mondo) condividere la notizia di quel che si fa, si pubblica, dei riconoscimenti e dei premi, delle traduzioni e delle ristampe, prosperano le freddezze, i piccoli fastidi nascosti ma non troppo, i risentimenti e qualche volta il franco disprezzo.
E te li devi aspettare, ti devi aspettare il messaggio di quel tale che ti accusa di esserti venduta al mercato, di quel talatro che dice che scrivi pattumiera. Ti devi aspettare il disprezzo tanto quanto il plauso, pure un po’ di più; e certo non è facile, ma è un allenamento anche questo, una sorta di esercizio spirituale.
Le prime volte, a leggere un commento cattivo, ti sembrerà di ritrovarti a origliare per caso da dietro una porta mentre nella stanza parlano male di te – tu passavi di lì, non avevi intenzione di ascoltare, e invece rimani con i piedi inchiodati a terra, le guance avvampate, senti ogni parola e a ogni parola ti vergogni di più. Succede. Poi ti ricordi che è successo anche alla Catherine di Northanger Abbey, un romanzo di Jane Austen che hai amato quando eri bambina, e capisci che non ci sono parole che ti toglieranno quello che hai amato, quello che cerchi, quello che ami. Pensi che la cosa migliore sia provare, per quanto possibile, a conservare quel tratto dell’infanzia, quello della vita segreta, una vita contigua al gioco, una vita che non solo nessuno ti vedeva vivere, ma che ti concedeva il privilegio di non doverti aspettare proprio niente. Non ti aspetti niente – non mi aspetto niente, allora, e se arrivano, il disprezzo e qualche volta una lode, cerco di accogliere l’uno e l’altra evitando drammi ma pure esultanze giulive che mi farebbero male.
È pur vero però che il grande acquario ha la funzione di ingigantire e di rendere sempre potenzialmente visibili fenomeni che comunque si verificherebbero, ma magari, senza il contributo dei social, un po’ più nascosti; l’impressione che ho è che il confronto continuo di pareri e opinioni delle cosiddette “bolle”, circoli di persone, anzi di utenti, che l’algoritmo titilla rimandando a ognuno i post, le opinioni, i commenti e le preferenze degli altri sulla base di un’appartenenza comune, di una condivisa visione delle cose, dia adito a un involontario uniformarsi dei gusti e degli interessi. Tutti guardano gli stessi film, le stesse serie, leggono gli stessi libri, nello stesso momento; e nello stesso momento li commentano, e strano a dirsi, o forse no, poco a poco i pareri si allineano, magari su due fronti contrapposti – chi adora smisuratamente quel film, quella serie, quel libro, e chi lo detesta.
Si crea, anche qualche volta per contrasto, un conformismo del gusto che pare non ammettere che qualcuno non abbia una sua opinione, entusiasta o delusissima, su quel certo prodotto dell’industria culturale, che proprio queste reazioni denunciano come un prodotto di consumo a tutti gli effetti, una merce, ma questo lato della questione in genere rimane sottotraccia – e se emerge, è per polarizzare nuove discussioni.
E allora, dentro questi gruppi che si rassicurano a vicenda sul proprio stesso gusto, sulla propria sensibilità, qualche volta sulla propria sofisticatezza, succede quello che sempre succede nei gruppi. Si cercano messaggi chiari, che purtroppo, a mio parere almeno, negano proprio l’incanto ambivalente della letteratura, la sua pericolosissima, deliziosa seduzione. E si cercano rassicurazioni: storie che facciano sentire intelligenti senza scuotere troppo, che sappiano risolversi in un “tema” che, di nuovo, possa essere messaggio; una gravità che permetta di mantenersi seriosi anche eventualmente nell’ironia, ammessa se ben dosata, personaggi possibilmente bistrattati dalla vita, problematici; bene se poveri, se ricchi o abbienti, invece, infelici abbastanza da non meritarsi l’accusa di essere troppo frivoli.
Generalizzo, certo, ma lo faccio perché io stessa, qualche volta, come un Paul Sheldon più approssimativo, mi sono sorpresa da sola a censurarmi le idee per rincorrere l’approvazione di un pubblico immaginario, immaginato. Poi ho pensato che non fa onore né a me né a chi mi legge, trattare anche solo nell’immaginazione i lettori come delle piccole Annie Wilkes. Ho pensato che mi voglio prendere la responsabilità di non piacere, lo devo alla bambina che sono stata e che amava i libri di gente che certo non si lasciava ricattare dalla paura di un commento a una stella su Ibs – del resto, i commenti a una stella non risparmiano neanche loro, e nessun libro da questo è sminuito.
Gran parte della fatica, nel mio lavoro attuale – e certo, mi direte, ci sono fatiche ben più ardue – consiste nel mantenere un equilibrio fra i rischi della vanità e quelli della frustrazione. Il giorno che troverò un modo per riuscirci, per restare in bilico senza scivolare troppo di qua o di là, festeggerò la mia liberazione; nel frattempo mi sforzo più che posso di coltivare l’arte rinascimentale della sprezzatura, di non prendere troppo sul serio il mio lavoro e i miei drammi, di tenere gli occhi ben aperti sul mondo, non solo quello virtuale, e soprattutto, di non aspettarmi mai niente.
L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, scrittrice, filosofa e collaboratrice de ilLibraio.it, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni. Scrive per diverse testate, e collabora con radio, tv e scuole di scrittura.
Fonte: www.illibraio.it
Scarica gli ebook gratuiti di IoScrittore.
Tanti consigli per migliorare e rendere efficace il tuo romanzo fin dalla prima pagina.
Gratis i consigli di scrittura degli autori bestseller e dei loro editor. - Edizione 2025
Condividi